Elie Wiesel ha scritto La notte come resoconto autobiografico in cui racconta la sua personale esperienza di prigioniero e superstite nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald.
Affetto da dissenteria, mio padre era sdraiato nel suo recinto, e altri cinque malati con lui. Io gli ero seduto accanto, vegliandolo, ma non osando più credere che avrebbe potuto sfuggire alla morte. E tuttavia facevo di tutto per dargli delle speranze.
Tutto a un tratto si drizzò sulla sua cuccetta e appoggiò le labbra febbricitanti contro il mio orecchio:
– Eliezer… Bisogna che ti dica dove si trovano l’oro e il denaro che ho sotterrato… In cantina… Tu sai…
E si mise a parlare sempre più in fretta, come se temesse di non avere più il tempo di dirmi tutto. Cercai di spiegargli che tutto non era ancora finito, che saremmo tornati insieme a casa, ma lui non voleva più ascoltarmi, non poteva più ascoltarmi. Era sfinito. Un filo di bava mista a sangue gli colava dalle labbra. Aveva gli occhi chiusi, ansimava.
Per una razione di pane riuscii a cambiare di posto con un detenuto di quel blocco. Nel pomeriggio arrivò il dottore e io andai subito a dirgli che mio padre era molto malato.
– Portalo qui!
Gli spiegai che non poteva tenersi sulle gambe, ma il medico non voleva sentir ragione. Alla meno peggio riuscii a portargli mio padre. Lo fissò, poi l’interrogò seccamente:
– Che vuoi?
– Mio padre è malato – risposi io al suo posto… – Dissenteria.
– Dissenteria? Non mi riguarda, io sono un chirurgo. Andate! Fate posto agli altri!…
Le mie proteste non servirono a nulla.
– Non ne posso più, figliolo… Riportami nel mio recinto…
Ce lo riportai e l’aiutai a stendersi. Aveva i brividi.
– Cerca di dormire un po’, papà. Cerca di addormentarti…
Respirava a fatica, pesantemente. Teneva gli occhi chiusi, ma io ero convinto che vedesse tutto, che vedesse, adesso, la verità di ogni cosa.
Un altro dottore arrivò nel blocco, ma mio padre non volle più alzarsi: sapeva che era inutile.
Questo medico non veniva peraltro che per finire i malati. Lo sentii gridare che erano dei poltroni, che volevano soltanto restare a letto… Pensai di saltargli al collo, di strozzarlo, ma non ne avevo né il coraggio né la forza: ero inchiodato all’agonia di mio padre. Le mani mi facevano male da quanto mi prudevano: strozzare il dottore e gli altri! Incendiare il mondo! Assassini di mio padre! Ma il grido mi restava in gola.
Tornando dalla distribuzione del pane trovai mio padre che piangeva come un bambino:
– Figliolo, mi picchiano!
– Chi?
Credevo che delirasse.
– Lui, il francese… E il polacco… Mi hanno picchiato… Una ferita di più nel cuore, un odio supplementare, una ragione in meno per vivere.
– Eliezer… Eliezer… digli di non picchiarmi… Non ho fatto nulla… Perché mi picchiano?
Mi misi a insultare i suoi vicini, che si burlarono di me. Promisi loro del pane, della zuppa: ridevano. Poi si arrabbiarono: non potevano più sopportare mio padre perché non poteva più trascinarsi fuori per fare i suoi bisogni.
Il giorno dopo mio padre si lamentò che gli avevano preso la sua razione di pane.
– Mentre dormivi?
– No, non dormivo. Si sono gettati su di me e me l’hanno strappato… E mi hanno picchiato… Ancora una volta… Non ne posso più, figliolo… Un po’ d’acqua…
Sapevo che non doveva bere, ma mi implorò così a lungo che cedetti. L’acqua era per lui il peggior veleno, ma cosa potevo fare ancora per lui? Con l’acqua, senza l’acqua, sarebbe comunque finita presto…
– Tu almeno abbi pietà di me…
Aver pietà di lui! Io, il suo unico figlio! Così passò una settimana.
– È tuo padre quello lì? – mi domandò il responsabile del blocco.
– Sì.
– È molto malato.
– Il dottore non gli vuol far nulla.
Mi guardò negli occhi:
– Il dottore non gli può far nulla. E neanche tu. Appoggiò la sua grande mano pelosa sulla mia spalla e aggiunse:
– Ascoltami bene, piccolo; non dimenticare che sei in un campo di concentramento. Qui ognuno deve lottare per se stesso e non pensare agli altri. Neanche al proprio padre. Qui non c’è padre che tenga, né fratello, né amico. Ognuno vive e muore per sé, solo. Ti do un buon consiglio: non dare più la tua razione di pane e di zuppa al tuo vecchio padre. Tu non puoi fare più nulla per lui, e così invece ti stai ammazzando. Tu dovresti al contrario ricevere la sua razione…
Lo ascoltai senza interromperlo. Aveva ragione, pensavo nell’intimo di me stesso, senza che osassi confessarmelo. Troppo tardi per salvare il tuo vecchio padre, mi dicevo. Potresti avere due razioni di pane, due razioni di zuppa…
Una frazione di secondo solamente, ma mi sentii colpevole. Corsi a cercare un po’ di zuppa e la diedi a mio padre, ma a lui non andava molto: non desiderava che dell’acqua.
– Non bere acqua, mangia un po’ di zuppa…
– Mi sto consumando… Perché sei così cattivo con me, figliolo?… Un po’ d’acqua…
Gli portai l’acqua. Poi lasciai il blocco per l’appello. Ma tornai sui miei passi e mi stesi sulla cuccetta sopra alla sua: i malati potevano restare nel blocco. Mi sarei dato per malato, visto che non volevo abbandonare mio padre.
Tutto intorno regnava adesso il silenzio, turbato soltanto dai gemiti. Davanti al blocco le SS davano ordini. Un ufficiale passò davanti ai letti. Mio padre implorava:
– Figliolo, dell’acqua… Mi sto consumando… Le mie viscere…
– Silenzio, laggiù! – urlò l’ufficiale.
– Eliezer, – continuava mio padre – dell’acqua…
L’ufficiale gli si avvicinò e gli gridò di tacere, ma mio padre non lo sentiva e continuava a chiamarmi. Allora l’ufficiale gli dette una violenta manganellata sulla testa.
Io non mi mossi. Temevo, il mio corpo temeva a sua volta un colpo.
Mio padre emise ancora un rantolo, e fu il mio nome: «Eliezer».
Lo vedevo ancora respirare, a scatti. Non mi mossi.
Quando scesi dalla mia cuccetta, dopo l’appello, potei vedere ancora le sue labbra mormorare qualcosa in un tremito. Chinato sopra di lui restai più di un’ora a guardarlo, a imprimere in me il suo volto insanguinato, la sua testa fracassata.
Poi dovetti coricarmi. Mi arrampicai di nuovo nella mia cuccetta, sopra mio padre, che viveva ancora. Era il 28 gennaio 1945.
Mi svegliai il 29 gennaio all’alba. Al posto di mio padre giaceva un altro malato. Dovevano averlo preso prima dell’alba per portarlo al crematorio. Forse respirava ancora…
Non ci furono preghiere sulla sua tomba; nessuna candela accesa in sua memoria. La sua ultima parola era stata il mio nome. Un appello, e io non avevo risposto.
Non piangevo, e non poter piangere mi faceva male: ma non avevo più lacrime. E poi, al fondo di me stesso, se avessi scavato nelle profondità della mia coscienza debilitata, avrei forse trovato qualcosa come: finalmente libero!…
Elie Wiesel

Lettura e interpretazione di Danilo Spadoni.
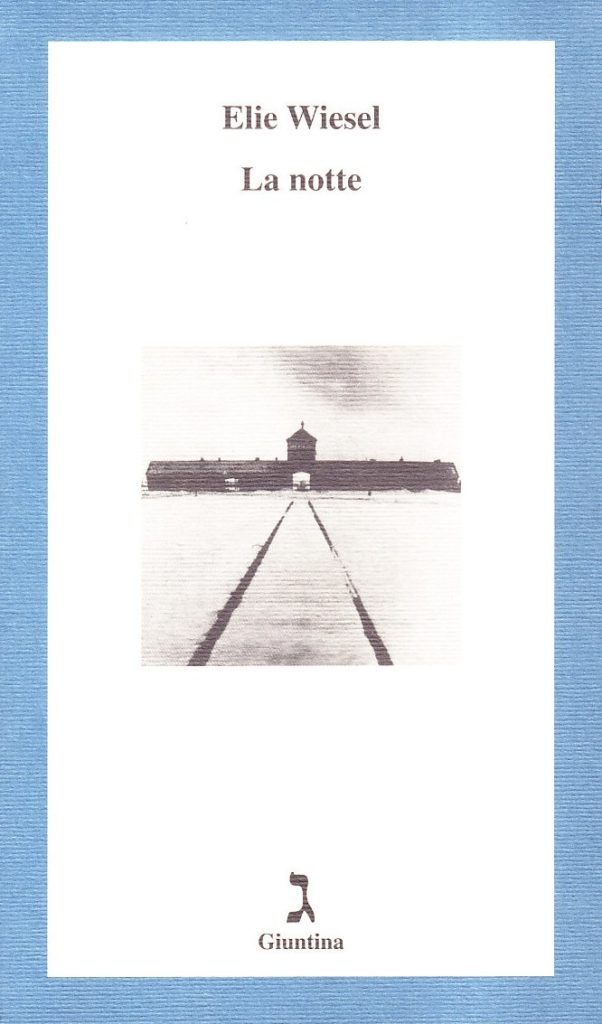
Testo tratto da Elie Wiesel, La notte, Firenze, Giuntina, 1995.